Tempo di lettura stimato: 5 minuti
 Stampa questa storia
Stampa questa storia
Quello che è noto come eccidio delle fonderie di Modena rappresenta il picco più alto delle lotte per il lavoro e i diritti “all’alba della Repubblica”. Il 9 gennaio 1950 l’imprenditore Adolfo Orsi riapre le Fonderie Riunite dopo una lunga serrata. Nessuno degli operai assunti in precedenza può rientrare al suo posto, perché gli iscritti alla FIOM non sono graditi alla proprietà. Per evitare l’ingresso dei nuovi assunti, disperati e non sindacalizzati, la CGIL organizza uno sciopero generale. Mentre i manifestanti presidiano gli accessi allo stabilimento, la tensione cresce. Le autorità dello Stato temono l’innesco di una protesta rivoluzionaria e sono disposte a usare il massimo grado della forza.
A metà mattina la forza pubblica, debitamente preparata dalla violenza e spaventata dalla fama sovversiva dei modenesi, spara su un gruppo che sta attraversando i binari. Tre lavoratori cadono a terra uccisi e altrettanti perdono la vita nelle due ore successive, mentre 140 manifestanti restano feriti. Le autorità denunciano l’assalto armato operaio, ma le forze dell’ordine non subiscono perdite né danni. Gli scioperanti non hanno bombe né fucili: parecchi soffrono per lesioni alla schiena, poiché di fronte alle raffiche possono solo scappare.
Quel mattino d’inverno Modena vive un punto di non ritorno. La stagione della “fabbrica democratica”, spazio del controllo operaio e della socialità popolare, si conclude con il ritorno dei vecchi rapporti di forza. Gli imprenditori soffocano le proteste e riprendono le redini degli stabilimenti, ma non riportano le lancette del tempo agli anni Trenta. Niente produzione di guerra, niente mercato protetto, niente profitti: di lì a pochi anni le grandi industrie modenesi chiudono. Al loro posto nascono villaggi artigiani e cooperative di lavoratori. Modena vive il suo boom economico nelle mani dei tanti licenziati che si mettono in proprio e affrontano il mercato creando i distretti industriali. Un modello di sviluppo disperato e ingegnoso, che affonda le proprie radici nella storia di una città e di una provincia che hanno sempre dovuto lottare per mestiere.
Fin dalla seconda metà dell’800, quando il bracciantato è ancora per molti la risposta alla miseria, lo sfruttamento, la prevaricazione e i ricatti accompagnano uomini e donne nei campi e nelle risaie. Si cerca nelle fabbriche quella sicurezza che la stagionalità del lavoro agricolo non può offrire, ma non si migliora di molto la propria condizione quando il bisogno costringe a sopportare l’insopportabile. E così raccoglitori di frutta e cernitrici, barrocciai e mondine, manovali e operaie della Manifattura tabacchi, tutti condividono la stessa disperazione, che per alcuni diventerà rabbia e poi lotta: contro la miseria, il fascismo, la guerra. Sui pedali si va al lavoro, sui pedali si protesta, sui pedali si combatte la Resistenza.
Perché ricordare e raccontare oggi le storie di chi ha lottato per mestiere? Per accendere nuove domande, per capire chi siamo, per cercare risposte sul nostro Oggi.
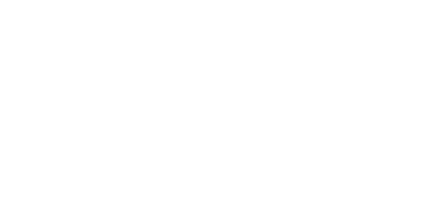








Lascia un commento